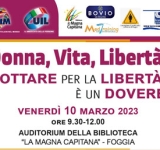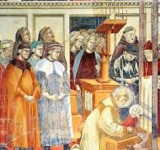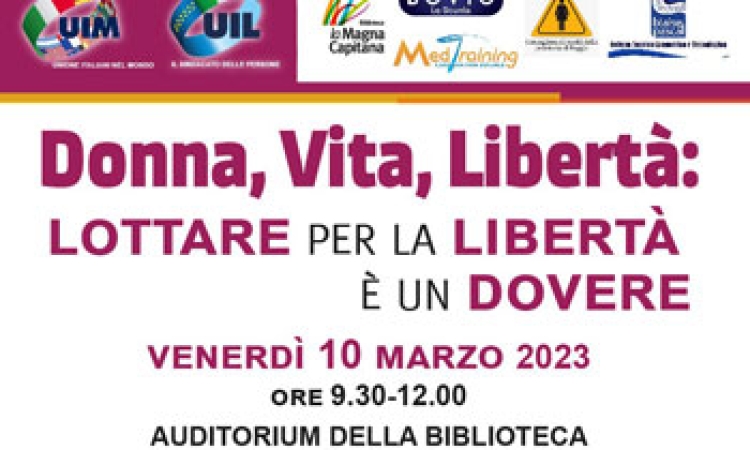Il primo quotidiano di informazione
on-line di Capitanata.
Stampa Sud:
Reg. Trib.di Foggia - R.P. 7/74. Tutti i Diritti Riservati
Direzione e Redazione:
Via Luigi Rovelli, 41 - 71122 Foggia.
Tel e Fax +39.0881.744812
La collaborazione a qualsiasi titolo
deve intendersi gratuita.
Segnalazioni : Gerardo Leone